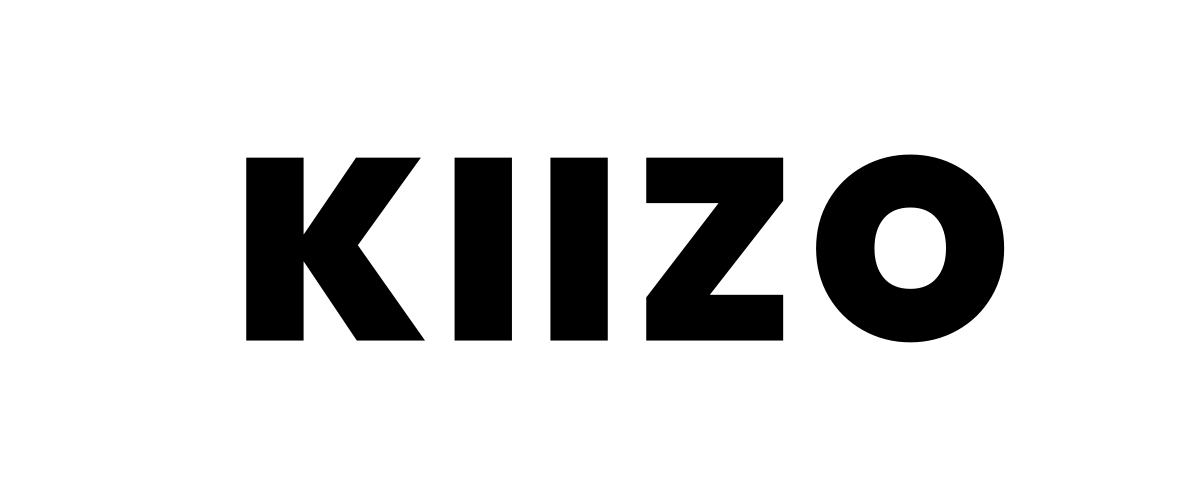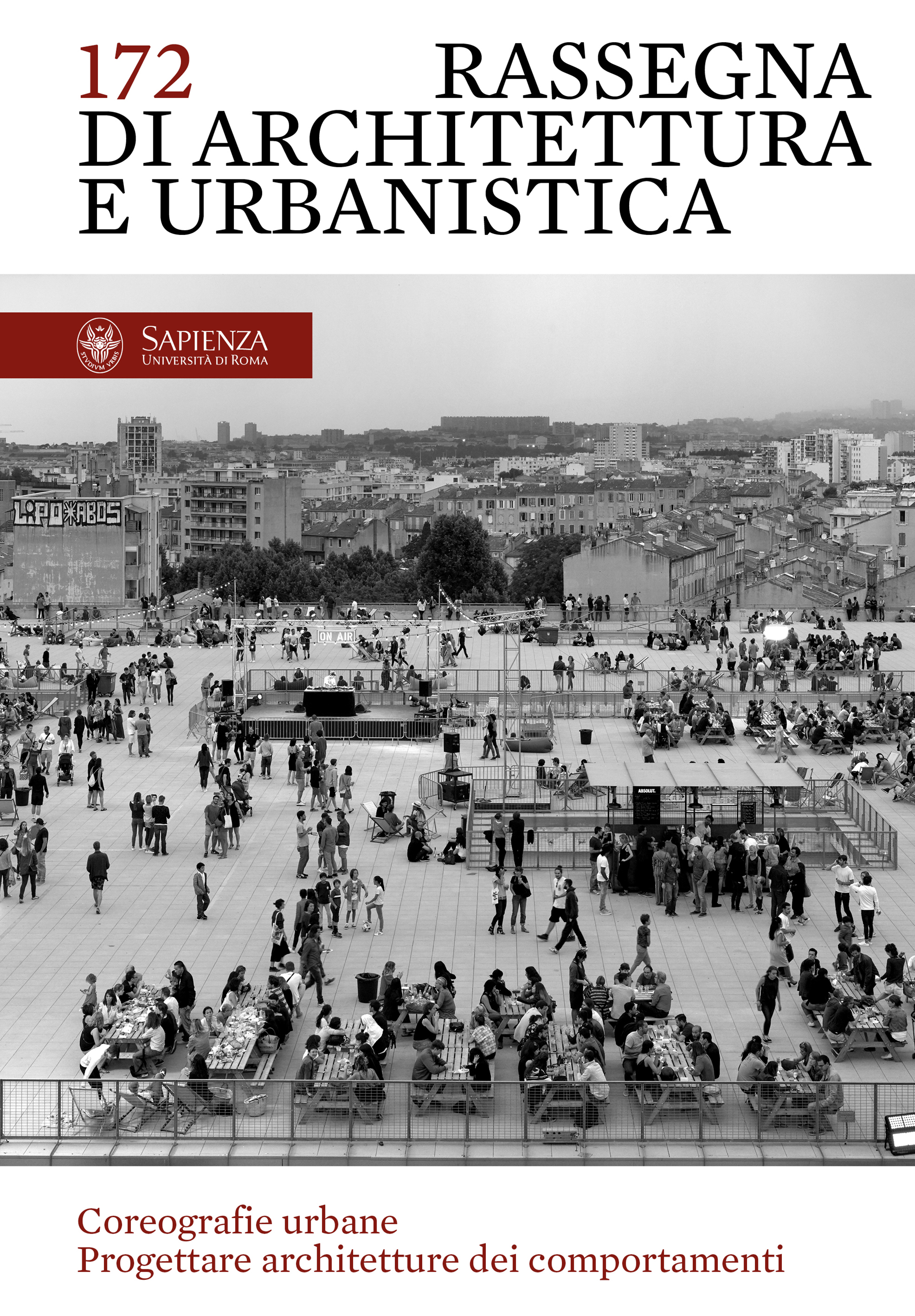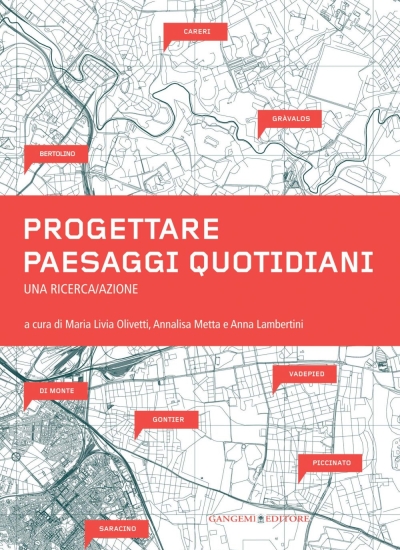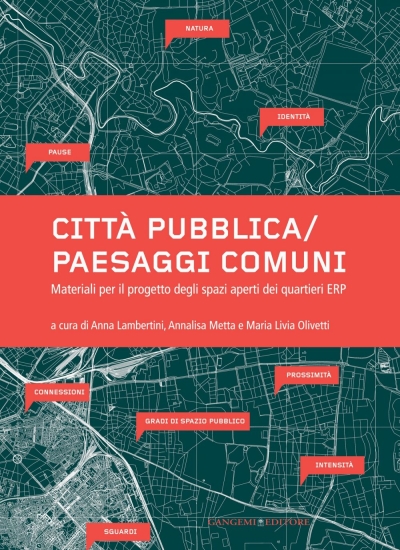Descripción
La condizione di «luogo abitato» sussiste purché
qualcuno vi porti i propri passi, vi indugi, vi si
adatti e, viceversa, lo adegui alle proprie esigenze,
pratiche e poetiche. L'abitare richiede l'esserci, richiede
il corpo. Non stupisce, perciò, che una lunga
tradizione europea abbia definito la città una
corporazione – nel senso letterale di aggregazione
di corpi – più che un ambito fisico1. In tempi recenti,
l'esperienza planetaria della temporanea espulsione
degli esseri umani dalla scena urbana, per
contenere la diffusione del contagio da Covid-19,
ha confermato che la città esiste come campo
relazionale tra corpi, la cui presenza/assenza e
il cui movimento sono azioni cognitive, configurative,
sociali, spaziali, politiche, architettoniche.
È questa la sostanza di cui si compone lo spazio
pubblico, dove molteplici coreografie – libere o indotte,
coordinate o anarchiche – si sovrappongono
e intrecciano continuamente, con diversi ritmi
e registri. Per questo lo spazio pubblico è l'orditura
geometrica, politica e coreutica portante della
città e il suo progetto è l'arte di disporre le condizioni
spaziali per interazioni sociali che si incarnano
nei corpi e che incessantemente si generano,
assopiscono, rinascono. Il progetto dello spazio
pubblico è regia del movimento. È la scrittura coreutica
dell'esperienza dello spazio abitato in comune,
sia che vi determini azioni obbligate, sia che
vi accolga e solleciti comportamenti spontanei e
imprevedibili. Osservare e progettare le coreografie
urbane significa interpretare i rapporti tra le
strutture spaziali della città, le esperienze fisiche
ed emotive delle e degli abitanti, i codici, le regole
e le convenzioni che le inducono o determinano.